23 novembre 2020
23 Novembre 2020
“Amate la vita, perché anch’io sono stata contenta di quella che Dio mi ha dato”
di Giovanna Abbagnara
Viviamo immersi in giorni di dolore. I bollettini dei contagi si susseguono insieme a quelli dei morti. Il terrore passa attraverso i social, i giornali, i tg, le dirette e giunge nelle nostre case seminando paura e disperazione e in qualche caso spinge anche a mettere fine alla propria vita. Mi sono interrogata spesso su qual è il ruolo dei cristiani di fronte alla pandemia. A come dobbiamo vivere questo tempo particolare. Come fronteggiare questo terrorismo psicologico che ci avvolge? Ho ricevuto nella mia formazione personale un buon metodo per fronteggiare quelle domande che sembrano spesso molto più grandi di noi ed è quello di guardare alla vita dei santi. Vedere come loro hanno vissuto e attraversato questa esistenza costellata di piccole e grandi difficoltà. Ero ancora adolescente quando il mio parroco ci presentò la figura di Benedetta Bianchi Porro. Un’esistenza breve, appena 50 anni ma come scrive il Cardinale Angelo Comastri nella prefazione alla sua biografia, che conservo tra i libri più belli della mia biblioteca personale, “la breve esistenza di Benedetta è ancora oggi un archivio di esperienze, dove è possibile fare continue scoperte”.
Benedetta nasce a Dovadola, in provincia di Forlì, l’8 agosto 1936. Di salute cagionevole, è colpita da una emorragia già alla nascita e la madre le conferisce il battesimo di necessità con acqua di Lourdes. La malattia diventa la sua via di santità: a tre mesi la poliomielite, che le lascia una gamba più corta dell’altra per cui sarà chiamata “la zoppetta”; poi deve indossare uno scomodissimo busto, per le deformazioni della schiena. Malgrado la guerra, la salute non proprio brillante e svariati traslochi, riesce a diplomarsi e ad iscriversi all’università ad appena 17 anni. Vuole diventare medico per aiutare gli altri, perché per sua sfortuna sa benissimo cos’è la malattia. I suoi studi di medicina le permettono un’autodiagnosi, confermata poi dai medici: la sua malattia si chiama morbo di Recklinghausen, ed è un proliferare di piccoli tumori che minano il sistema nervoso. Con straordinaria forza di volontà, malgrado la sordità, continua a studiare ed a sostenere gli esami, incontrando anche professori insensibili che si fanno beffe del suo handicap.
Un primo intervento chirurgico alla testa le provoca una paresi facciale; un secondo intervento al midollo, nel 1959, la paralizza completamente. Dopo aver attraversato la notte buia della sofferenza e della solitudine, essersi terrorizzata per lo spettro della cecità e della sordità, aver pianto sui più bei sogni che ha visto frantumarsi, finalmente una luce comincia ad illuminare il suo buio interiore. Gesù comincia a farsi strada nella sua vita e la sua è una presenza sempre più significativa e preziosa, che dà un senso alle giornate interminabili, al dolore fisico, al buio ed al silenzio che la circonda: “Mi accade di trovarmi a volte a terra, sotto il peso di una croce pesante. Allora Lo chiamo con amore e Lui dolcemente mi fa posare la testa sul suo grembo”. Attorno al suo letto tanti amici cercano di riempire la sua solitudine, ma tornano a casa pieni della serenità che trasmette, come quando riesce a sussurrare loro: “La vita in sé e per sé mi sembra un miracolo, e vorrei poter innalzare un inno di lode a Chi me l’ha data … Certe volte mi chiedo se non sia io una di quelle cui molto è stato dato e molto sarà chiesto…”. L’unico modo per comunicare sarà un alfabeto tracciato sul palmo della mano. “Nel mio calvario non sono disperata. Io so, che in fondo alla via, Gesù mi aspetta… Le mie giornate non sono facili: sono dure, ma dolci, perché Gesù è con me, col mio patire, e mi dà soavità nella solitudine e luce nel buio”, scrive l’1 giugno 1963 in risposta a un lettore di Epoca. Il disfacimento fisico non impedisce a Benedetta, fino a un certo punto, di scrivere lettere e diari che ci ridanno il mosaico di un’anima «straordinariamente semplice e semplicemente straordinaria», scrive sempre Comastri, perché innamorata di Cristo.
Nel 1962 la portano a Lourdes, alla ricerca di un miracolo che avviene, ma per la malata coricata sulla barella accanto. Ritorna a Lourdes l’anno dopo e questa volta il miracolo è per lei: non della guarigione fisica, ma della scoperta della sua vocazione alla croce: “Mi sono accorta più che mai della ricchezza del mio stato e non desidero altro che conservarlo”. Ci sono giorni in cui si accorge di aver bisogno di “attingere forza dalla Mamma celeste, poiché non so abituarmi come vorrei a vivere felicemente nel buio”, ma sempre più deve riconoscere che “nella tristezza della mia sordità, e nella più buia delle mie solitudini, ho cercato con la volontà di essere serena per far fiorire il mio dolore”. A gennaio 1964 si accorge che le sue condizioni generali sono peggiorate parecchio: “spero che la “chiamata” non si faccia attendere troppo”, dice serenamente agli amici. La chiamata arriva il 23 gennaio e si congeda da questo mondo con un messaggio di speranza: “Amate la vita, perché anch’io sono stata contenta di quella che Dio mi ha dato”.
Vai all'archivio di "Con gli occhi della fede"
Aiutaci a continuare la nostra missione: contagiare la famiglia della buona notizia
Cari lettori di Punto Famiglia,
stiamo vivendo un tempo di prova e di preoccupazione riguardo il presente e il futuro. Questo virus è entrato prepotentemente nella nostra quotidianità e ci ha obbligati a rivedere i tempi del lavoro, delle amicizie, delle Celebrazioni. Insomma, ha rivoluzionato tutta la nostra vita e non sappiamo fin dove ci porterà e per quanto tempo. Ci fidiamo delle indicazioni che provengono dal Governo e dagli organi sanitari preposti ma nello stesso tempo manifestiamo con la nostra fede che “il Signore ci guiderà sempre” (cfr Is 58,11).







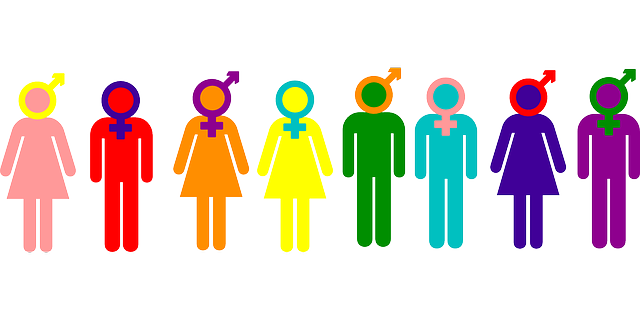


Lascia un commento